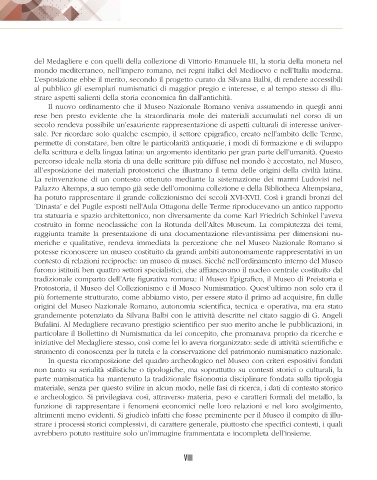Page 12 - Bollettino di Numismatica Studi e Ricerche n. 4/2024
P. 12
Gabriella Angeli Bufalini
del Medagliere e con quelli della collezione di Vittorio Emanuele III, la storia della moneta nel
mondo mediterraneo, nell’impero romano, nei regni italici del Medioevo e nell’Italia moderna.
L’esposizione ebbe il merito, secondo il progetto curato da Silvana Balbi, di rendere accessibili
al pubblico gli esemplari numismatici di maggior pregio e interesse, e al tempo stesso di illu-
strare aspetti salienti della storia economica fin dall’antichità.
Il nuovo ordinamento che il Museo Nazionale Romano veniva assumendo in quegli anni
rese ben presto evidente che la straordinaria mole dei materiali accumulati nel corso di un
secolo rendeva possibile un’esauriente rappresentazione di aspetti culturali di interesse univer-
sale. Per ricordare solo qualche esempio, il settore epigrafico, creato nell’ambito delle Terme,
permette di constatare, ben oltre le particolarità antiquarie, i modi di formazione e di sviluppo
della scrittura e della lingua latina: un argomento identitario per gran parte dell’umanità. Questo
percorso ideale nella storia di una delle scritture più diffuse nel mondo è accostato, nel Museo,
all’esposizione dei materiali protostorici che illustrano il tema delle origini della civiltà latina.
La reinvenzione di un contesto ottenuto mediante la sistemazione dei marmi Ludovisi nel
Palazzo Altemps, a suo tempo già sede dell’omonima collezione e della Bibliotheca Altempsiana,
ha potuto rappresentare il grande collezionismo dei secoli XVI-XVII. Così i grandi bronzi del
‘Dinasta’ e del Pugile esposti nell’Aula Ottagona delle Terme riproducevano un antico rapporto
tra statuaria e spazio architettonico, non diversamente da come Karl Friedrich Schinkel l’aveva
costruito in forme neoclassiche con la Rotunda dell’Altes Museum. La compiutezza dei temi,
raggiunta tramite la presentazione di una documentazione rilevantissima per dimensioni nu-
meriche e qualitative, rendeva immediata la percezione che nel Museo Nazionale Romano si
potesse riconoscere un museo costituito da grandi ambiti autonomamente rappresentativi in un
contesto di relazioni reciproche: un museo di musei. Sicché nell’ordinamento interno del Museo
furono istituiti ben quattro settori specialistici, che affiancavano il nucleo centrale costituito dal
tradizionale comparto dell’Arte figurativa romana: il Museo Epigrafico, il Museo di Preistoria e
Protostoria, il Museo del Collezionismo e il Museo Numismatico. Quest’ultimo non solo era il
più fortemente strutturato, come abbiamo visto, per essere stato il primo ad acquisire, fin dalle
origini del Museo Nazionale Romano, autonomia scientifica, tecnica e operativa, ma era stato
grandemente potenziato da Silvana Balbi con le attività descritte nel citato saggio di G. Angeli
Bufalini. Al Medagliere recavano prestigio scientifico per suo merito anche le pubblicazioni, in
particolare il Bollettino di Numismatica da lei concepito, che promanava proprio da ricerche e
iniziative del Medagliere stesso, così come lei lo aveva riorganizzato: sede di attività scientifiche e
strumento di conoscenza per la tutela e la conservazione del patrimonio numismatico nazionale.
In questa ricomposizione del quadro archeologico nel Museo con criteri espositivi fondati
non tanto su serialità stilistiche o tipologiche, ma soprattutto su contesti storici o culturali, la
parte numismatica ha mantenuto la tradizionale fisionomia disciplinare fondata sulla tipologia
materiale, senza per questo svilire in alcun modo, nelle fasi di ricerca, i dati di contesto storico
e archeologico. Si privilegiava così, attraverso materia, peso e caratteri formali del metallo, la
funzione di rappresentare i fenomeni economici nelle loro relazioni e nel loro svolgimento,
altrimenti meno evidenti. Si giudicò infatti che fosse preminente per il Museo il compito di illu-
strare i processi storici complessivi, di carattere generale, piuttosto che specifici contesti, i quali
avrebbero potuto restituire solo un’immagine frammentata e incompleta dell’insieme.
IX
VIII IX